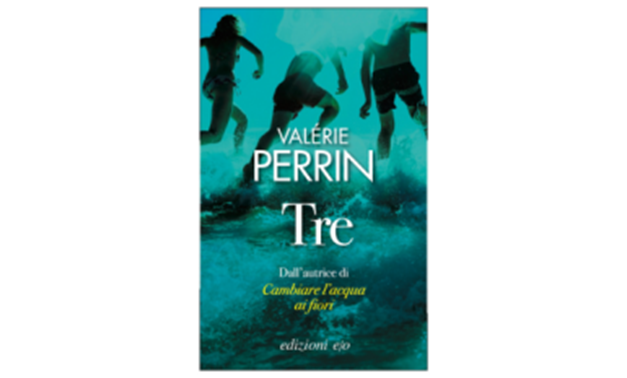«Spesso la malattia separa, allontana, distrugge. Qualche volta invece genera, allaccia, moltiplica l’amore»
Un libro forte, toccante, bellissimo (e uso questo aggettivo di proposito, perché di bellezza si parla in questo lettura) che affronta temi scottanti come la malattia e la disabilità. Un memoir scritto in prima persona sotto forma di lettera aperta alla figlia Daria, nata con una malattia rara, la oloprosencefalia, una importante disabilità che non le permette alcuna indipendenza ed espressione comunicativa se non attraverso un sorriso o un lamento.
Daria è la figlia desiderata, la cui iniziale”D”si pone nel nome dell’autrice, tra Ada e Alfredo, anello di congiunzione simbolico e affettivo dei genitori. Daria è il frutto della propria fertilità, motivo di gioia ma anche di rabbia e sconforto perché è impossibile non farsi carico delle mancanze e sofferenze di chi è sangue del tuo sangue.
Ada riesce con un linguaggio chiaro ed essenziale, senza vittimismo o pietismo, a descrivere tutta la diversità del suo «altro mondo», un mondo scomodo, costruito sulla completa dedizione, fatto di sacrifici e rinunce che trovano un senso solo nella parola “amore”.
Una storia di disabilità e di malattia incurabile, che porta a una consapevolezza profonda, in cui «col tempo si smette di accanirsi a cercare risposte, di affannarsi, di voler andare altrove. Non rassegnazione, piuttosto una forma di accettazione attiva: si smette di combattere “contro”. Si risparmiano energie e si pensa a combattere “per”.
Una storia che riapre la tanto discussa questione dell’aborto terapeutico, una scelta
soprattutto femminile che genera mille interrogativi
spesso senza risposta «Sono forse per la
morte io?[...] Di quale vita si parla? Della mia? Della tua?[...]Quante
sofferenze ti aspettano? Chi può decidere se una vita vale la pena di essere
vissuta?[... ]Solo il bisogno di rivendicare per tutte il diritto alla scelta,
anche per quelle che avevano scelto diversamente».
Ma anche un atto di denuncia sociale contro un mondo a misura di persone sane, che spesso non favorisce la disabilità assegnandole un ruolo marginale. Per fortuna non sempre è così: esistono professionisti, «persone che non perdono tempo a rimpiangere quel che ti manca ma sfruttano quel poco che hai», istituzioni che cercano nonostante le barriere logistiche e culturali di andare oltre e offrire qualcosa di più.
Una storia di solitudine profonda perché «avere un figlio invalido significa essere soli. Irrimediabilmente, definitivamente soli. Indietro non si torna. Uguale a prima non sarà mai più».
Una storia di malattia, il tumore di Ada che irrompe all’improvviso, rompendo l’equilibrio complesso madre – figlia, aprendo un importante interrogativo sul futuro di Daria e di chi rimane.
Ecco emergere l’importanza delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, strumento poco conosciuto, utile per pianificare e dare continuità e senso alla propria vita e a quella di chi rimarrà.
“Come d’aria” è soprattutto la storia di una donna – figlia, ballerina, scrittrice, moglie, madre, amica – che ha lottato per la vita fino alla fine (anche se non ha mai amato la parola “battaglia”) e nonostante sia morta a soli cinquantasette anni, ha vissuto una vita piena e degna di essere vissuta.
Una scrittura intensa, magistrale quasi poetica: parole e frasi che dalla logica arrivano dritte al cuore, come aghi sottili scuotendoci dalla stasi emotiva. Impossibile non addolorarsi con lei, non commuoversi alle sue strategie di sopravvivenza, non piangere ai suoi tentativi falliti di risalita. Impossibile restare in silenzio e non applaudire alla grande Donna che è stata: Ada D’Adamo, Ada, figlia del primo uomo.
Come d’aria di Ada D’Adamo (ed Elliot 2023)