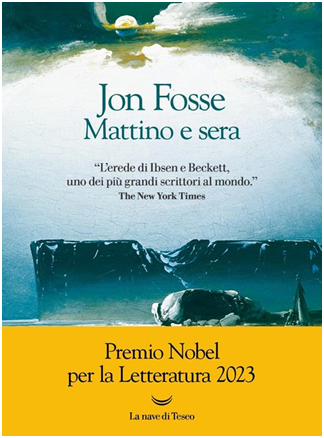«Per
gli esseri umani la vita ha un senso perché è una storia […]
E nelle storie il finale conta».
La vita di un essere umano è la biografia della grande
biblioteca dell’Umanità, ognuno ha la sua storia, dettata dalle proprie
origini, dalle vicende che l’hanno determinata sulla base delle proprie scelte (o non scelte) desideri, volontà… e
ogni capitolo ha il suo valore, non per ultimo quello del fine vita, momento
conclusivo e proprio per questo, di straordinaria importanza. Perché sminuirlo
e non considerarlo in tutta la sua valenza e rilevanza?
Atul Gawande,
medico chirurgo statunitense, ci porta a riflettere su questo momento
fondamentale della vita, che dobbiamo rendere interessante e significativo (per
chi se ne va ma anche per chi resta) e non demonizzarlo come invece accade.
Molte le tematiche affrontate che provo a riassumere nei
capitoli dedicati.
Indipendenza. Indipendenza
è una parola che spesso troviamo contrapposta al problema della “vecchiaia”,
fase della vita di un individuo in cui si assiste a un decadimento fisico e
cognitivo più o meno lento. Lo sviluppo tecnologico, scientifico, informatico e
medico ha determinato un progresso tale da portare la popolazione a vivere più
a lungo, a invecchiare, condizione che non sussisteva nei secoli passati quando
l’età media era intorno ai cinquant’anni. Ovviamente con l’aumento dell’età
sono aumentate le patologie croniche che la medicina controlla con la terapie,
ma che possono creare disabilità e disagi tali da minare spesso l’indipendenza
delle persone. Questa è la grande piaga del nostro secolo, la cura e
l’assistenza di un’ ampia fascia di popolazione che non è più autosufficiente e
ha bisogno di assistenza e cura continua spesso da parte di personale
competente. Con la scomparsa della famiglia patriarcale, l’anziano è diventato
sempre più una questione sociale, di indirizzo medico assistenziale e sempre
meno familiare. I figli stessi sono già in età avanzata nel gestire il proprio
genitore, non vivono con lui, e quando questi perde la propria autonomia, il
problema emerge improvviso e devastante. Oggi le soluzioni (almeno nella nostra
realtà italo-europee) sono le badanti o istituzioni quali RSA, case di riposo,
istituti che permettono la gestione quotidiana di una persona non più
autosufficiente da parte di personale qualificato.
Tutto si disfa. Atul
Gawande ci mostra la vita di un individuo come una traiettoria sulla linea
delle ascisse, che la medicina e la sanità pubblica contemporanea hanno
cambiato radicalmente, come dicevo innanzi. Nei traumi, malattie a esito
infausto (come un infarto cardiaco, emorragia cerebrale massiva,ecc…) la
traiettoria ha un andamento costante e soddisfacente per qualità della vita
fino all’improvvisa caduta determinata dalla morte. Grazie alla Medicina e
Chirurgia, la traiettoria può essere modulata variando così a seconda delle
patologie. Nelle malattie tumorali l’andamento è costante e soddisfacente fino
a un declino più o meno lento nella fase finale della vita. Nella malattie
croniche invece si assiste a un andamento costantemente in discesa con cadute
improvvise (crisi e scompensi ) subito gestiti dalla medicina che riportano la
persona a un livello sempre inferiore rispetto a quello prima dell’evento
scatenante. Nell’invecchiamento fisiologico invece la traiettoria è una linea
che scende in maniera graduale verso il basso, fino all’esito finale. L’autore
ci fa notare che vivere così a lungo come viviamo oggi rappresenta un fenomeno
assai innaturale, in quanto la morte di vecchiaia in passato era cosa rara. Perché
si invecchia allora? Sembra che la genetica sia solo un frammento nella
spiegazione del quesito. Sembriamo progettati per funzionare a tutti i costi, e
ce lo dimostra il fatto che abbiamo due occhi, due reni, due orecchie, due
braccia… nel caso uno dei due venga a mancare. Illuminante questa
considerazione pur così semplice, nel giustificare il dualismo del nostro
corpo.
Ci sono alcune specializzazioni più attraenti per la
carriera di un medico (la chirurgia plastica, la radiologia, per es…) rispetto
ad altre come la geriatria (e io aggiungo le cure palliative) che deprivano di
una qualità importante della professione ovvero la possibilità di garantire la
speranza di vita a lungo termine. Molti medici lavorano poco volentieri con gli
anziani. Ovvio, mi viene da pensare, non è un settore della medicina che dà
soddisfazione e speranza, dal momento che dovremmo affrontare problemi
sconvenienti come l’accettazione dell’ inevitabile declino del corpo e quello del
fine vita, perché come asserisce A.G «il
sogno di tutti è vincere il tempo, l’ingrato compito del geriatra è farci
accettare che non ne siamo capaci».
Il problema fondamentale nella presa in carico dell’anziano
è che non si può prendere in considerazione solo ed esclusivamente le patologie
croniche (l’insufficienza renale, cardiaca, respiratori il diabete, ecc…) ma
tutta la persona nella sua interezza e globalità, in una visione individuale e soggettiva (ciò che è bene per quella
persona), familiare e sociale. I medici non geriatri spesso non riescono a fare
questa considerazione, forse per cultura, per mancanza di strumenti e di
risorse, per abitudine… indirizzandosi più sulla cura del sintomo e cercando la
soluzione per quello. E da qui nascono tutti i problemi.
Dipendenza. “Non è la morte che le persone molte anziane
mi dicono di temere. È quel che la precede: perdere l’udito, la memoria, gli
amici più cari, le abitudini di vita».
Negli Stati Uniti negli anni Cinquanta le case di carità per
l’assistenza agli anziani indigenti e malati chiusero determinando un grosso
problema sanitario e sociale. Ovviamente il tutto non poteva risolversi da
parte dell’ospedale, luogo destinato alla cura di eventi acuti e non alla
gestione delle patologie croniche. Cominciò così a delinearsi, una nuova concezione
di luogo di assistenza per la persona anziana con patologie croniche: la
moderna casa di riposo, nursing home
nata più dalla necessità di liberare posti letto dall’ospedale che per
risolvere i problemi legati alla terza età. Le nursing homes fiorirono come alberi in primavera arrivando a un
numero di tredicimila nel 1970 - documenta l’autore - col supporto anche di Medicaid,
il sistema di previdenza sociale americano. L’evoluzione c’è stata anche sulla
base di iniziative private che hanno cercato di ricreare case comunitarie in
cui l’anziano potesse giovarsi dell’assistenza necessaria e al contempo vivere
la parte conclusiva della propria vita sentendosi a casa propria.
Il problema di un luogo di cura e assistenza nella terza età non riguarda
solo la realtà statunitense, ma anche la nostra. Le case di riposo purtroppo
rimangono spesso istituzioni non centrate sulla persona ma su problematiche di
carattere sociale, gestionale, pratico, l’alternativa quando non ci sono altre
soluzioni.
Assistenza. Cos’è la
vecchiaia? Una serie di definizioni interessanti ce le fornisce l’autore
avvalendosi di alcune teorie «Secondo
alcuni è un mutamento che riflette la saggezza acquisita con una lunga
esperienza di vita. Altri ritengono che si tratti del risultato cognitivo di
cambiamenti dei tessuti cerebrali legati all’età. Altri ancora sostengono che
il cambiamento di comportamento sia imposto agli anziani e non rifletta ciò che
nel profondo del cuore essi vogliono veramente. I vecchi restringono le loro
mire perché le limitazioni imposte dal declino fisico e cognitivo non
consentono loro di perseguire gli obiettivi di un tempo, oppure perché il mondo
glielo impedisce per l’unica ragione che sono vecchi. A quel punto invece di
lottare si adattano, o per dirla in modo più triste si arrendono». E
l’arrendevolezza aggiungo io coincide purtroppo con la perdita dell’autosufficienza
nel paziente fragile (oppure è questa che la determina) , che non può più farsi
le proprie ragioni perché dipende da qualcun altro. E questa è la tomba della
persona, alienata nei propri desideri. Ma quali sono i desideri dell’anziano
fragile? È una domanda che dobbiamo sempre porci. Studi dimostrano che le
persone che risiedono nelle RSA come desiderio primario esprimono la condizione
di sentirsi a casa. Perché come dice A.G «La
casa è l’unico posto dove le proprie priorità regnano sovrane. A casa tua,
decidi tu come spendere il tuo tempo, come ripartire il tuo spazio, come
gestire i tuoi beni personali». Mentre purtroppo le case di assistenza non
mettono al centro i bisogni e i desideri della persona (alzarsi alla propria
ora, mangiare quando si ha fame, guardare alla tv ciò che si preferisce,
circondarsi di persone significative …) in quanto tutto ruota attorno a una
organizzazione standard che possa nella maniera più redditizia ottimizzare
l’assistenza, garantire sicurezza e soddisfazione dei bisogni primari appunto.
Interessante la carrellata di esperienze innovative di case
comunità che l’autore ci racconta, con l’obiettivo di realizzare proprio questa
possibilità. Esperienze che hanno più o meno funzionato, anche se «non esistono metodi validi per valutare il
successo di una struttura residenziale nell’aiutare i residenti a vivere. Mentre
in materia di salute e sicurezza, invece, disponiamo di criteri molto precisi».E
aggiunge in battuta finale: «è cosi che
vanno le cose […] i nostri vecchi non si ritrovano che con questo: un’esistenza
istituzionale, sotto controllo e sotto tutela, una risposta medica a problemi
medicalmente irrisolvibili, una vita pensata per essere sicura, ma priva di
interesse».
Una vita
migliore. Riportandoci l’esperienza di
Bill Thomas, medico e direttore di una casa di riposo, riferisce quelle che
«chiamava le “tre piaghe” della vita in
casa di riposo: la noia, la solitudine, l’impotenza». Perciò introdusse
cani, gatti, uccellini, un giardino con piante di cui i residenti potessero
prendersi cura, offrendo loro una ragione di vita.
Quale dovrebbe essere l’ obiettivo delle residenze sanitarie
assistite, delle case per anziani, di riposo o comunque le vogliamo chiamare?
Aiutare le persone autosufficienti e non autosufficienti, nella soddisfazione
dei bisogni primari, preservando dignità e valore della vita. Cosa occorre?
Luoghi ridimensionati, più intimi, dove esista la privacy, pur garantendo
protezione e sicurezza. Non mancano nella narrazione molti esempi di esperienze
americane in cui sono stati raggiunti risultati simili: l’autonomia, la
sicurezza nel rispetto della propria libertà di azione, la dignità, l’orgoglio di
vivere in coerenza con le proprie ideologie. Perché è questo che l’anziano
vuole, e che vorremo anche noi quando lo saremo, «continuare a scrivere la nostra storia […] mantenere la libertà di plasmare la nostra vita in modo coerente
con la nostra personalità e con ciò in cui crediamo».
«La lotta
dell’essere mortale è la lotta per mantenere l’integrità della propria vita: è
la battaglia per evitare di finire così degradati, prostrati, o sottomessi da
non aver più un legame con ciò che siamo stati o con ciò che vogliamo essere».
Lasciare
andare. «Dobbiamo
porre un freno agli imperativi di tipo prettamente medico e resistere al nostro
bisogno di armeggiare, riparare, controllare». Una frase
forte che in poche parole dice tutto. Non
è facile in una cultura in cui dobbiamo sempre vincere, fare i conti con la
morte che rappresenta la sconfitta. Ecco perché è più facile agire, accanirsi,
che lasciare andare e far sì che la vita segua il corso naturale degli eventi.
Siamo impreparati, ignoranti, non conosciamo le modalità di accompagnamento alla
morte. In passato esistevano manuali popolari, come la versione medievale sull’
“ars moriendi” pubblicato in latino
dove «la gente credeva che la morte
dovesse essere affrontata stoicamente, senza paura né autocommiserazione, e
senza altra speranza se non quella riposta nella misericordia di Dio». Oggi
esiste «L’hospice, che ha tentato di
proporre un nuovo ideale di modo di morire. Non tutti hanno accettato i suoi
rituali, ma coloro che lo hanno fatto stanno contribuendo alla composizione
negoziata di un’“ars moriendi” della nostra era. In questo negoziato, tuttavia,
trova anche espressione una battaglia: non solo contro la sofferenza ma anche
contro lo slancio apparentemente inarrestabile del trattamento medico». La
scelta dell’hospice non accelera il processo del morire, anzi, come dimostrano
alcuni studi «Si vive più a lungo solo quando
si smette di cercare di vivere più a lungo».
È più difficile parlare chiaramente al paziente della prognosi infausta,
dirgli la verità. Non siamo preparati culturalmente e spesso non lo è neppure
lui. È più facile continuare a infondere speranza, a illuderlo con la
possibilità di nuove terapie. «I medici
appaiono particolarmente attenti a non frustrare le aspettative dei malati.
Hanno molta più paura di peccare per pessimismo che per ottimismo». Per
questo è fondamentale la Pianificazione delle cure in cui insieme alla persona,
il medico, l’equipe, comincia un percorso di cura che non sarà finalizzato alla
guarigione, alla cura del sintomo della malattia (cure attive), ma
all’alleggerimento della sofferenza creata dalla malattia (cure palliative), ai
fini di una migliore qualità di vita della persona stessa e dei familiari. Un
processo che richiede tempo e che si avvale della comunicazione come strumento
base, per ascoltare, fornire indicazioni e conoscenze, accogliere e stabilire
insieme alla persona e ai familiari il piano di cura.
«Le
persone gravemente ammalate hanno altre preoccupazioni oltre al semplice
prolungamento della loro vita […] vogliono evitare di soffrire, stare a più
stretto contatto con familiari e amici, mantenere la lucidità mentale, non
essere di peso agli altri e riuscire a dare un senso di completezza alla
propria esistenza. Il nostro sistema di assistenza sanitaria tecnologica si è
dimostrato clamorosamente incapace di soddisfare queste esigenze». La
tecnologia purtroppo può andare avanti nel mantenere vitali gli organi,
superando la soglia della volontà e dignità della persona e questo è ciò che
dobbiamo assolutamente non permettere.
Conversazioni
difficili. Le conversazioni difficili sono quelle che scavano dentro l’intimità
della persona, sono quelle che portano a scelte sensate, a prese di coscienza e
decisione, sono le conversazioni che permettono alla persona di ricevere le
giuste informazioni sulla propria condizione di salute, di metabolizzarla con
l’aiuto dell’interlocutore, nel rispetto della propria libertà e dignità.
Siamo passati dalla relazione “paternalistica” del passato (in cui
il medico sapeva cosa era bene per il paziente e decideva) a una relazione di
tipo “informativo” in cui al paziente vengono forniti dati e cifre (il medico è
il tecnico esperto, il paziente il cliente e sta a lui la decisione). Ezekile e
Linda Emanuel, due studiosi di etica, hanno ravvisato «un terzo tipo di relazione che hanno definito “Interpretativa” in cui
il ruolo del dottore è aiutare i pazienti a stabilire ciò che vogliono […] Gli
esperti l’hanno chiamato processo decisionale condiviso».
Atul Gawande spiega l’efficacia di questo terzo tipo di relazione raccontandoci
l’esperienza personale con il fine vita del padre, affetto da una forma
tumorale cervicale.
La vita ci impone spesso cambiamenti repentini che dobbiamo fare
propri, ridefinendo noi stessi, ovvero riadattandoci, creando nuove identità al
fine di ricollocarsi nella vita con uno scopo, una ragione. «È questo che si intende per avere autonomia:
può succedere di non poter controllare le circostanze della vita, ma riuscire a
essere l’autore della propria vita significa poter controllare quel che si fa
con le circostanze che ci vengono date».
Le conversazioni difficili sono quelle che scoprono la pentola con
dentro i fantasmi, le pene, le angosce più intime, quelle legate alla malattia
infausta e alle conseguenze terribili che portano dolore e atroci sofferenze.
Rendere possibile, creare l’opportunità di una conversazione difficile può
anche allungare la vita oltre a renderla migliore.
Coraggio. «Il
coraggio è la forza di fronte alla conoscenza di ciò che si deve temere e di
ciò che si deve osare». Il coraggio durante la malattia o la vecchiaia è voler
sapere la verità su ciò che si teme o si spera, e il coraggio di affrontare la
realtà della mortalità. Ma, dice Atul Gawande «la vera sfida è decidere se a dover prevalere sono le proprie paure o
le proprie speranze».
Studi sul dolore dimostrano
che è il picco-fine del dolore e non la durata del dolore a esprimere
l’intensità di sofferenza data dalla memoria. «Per gli esseri umani la vita ha un senso perché è una storia. Una
storia ha un senso d’insieme, e la sua traiettoria è determinata da momenti significativi,
che sono quelli in cui succede qualcosa […] questo funzionamento è
profondamente influenzato da come le cose vanno a finire […] e nelle storie il
finale conta»
Il coraggio potrebbe essere l’equilibrio tra il controllo e l’impotenza.
«La vita assistita è molto
più difficile della morte assistita, ma ha anche potenzialità
straordinariamente più grandi».
E concludo con questa bellissima frase:
«La
società tecnologica ha dimenticato quello che gli studiosi chiamano il ruolo
del morente” e quanta importanza esso abbia per le persone che vedono
approssimarsi al fine. Le persone vogliono condividere i ricordi, trasmettere
saggezze e oggetti personali, definire le relazioni, fare pace con Dio e
assicurarsi che chi resta non abbia problemi. Vogliono concludere la loro
storia a modo loro. e se questo è vero, il modo in cui, per ottusità e incuria,
stiamo negando alle persone la possibilità di ricoprirlo, dovrebbe essere per
noi motivo di eterna vergogna».
E infine:
«Essere mortale significa
anche sforzarsi di sopportare i vincoli della nostra biologia, ovvero i limiti
imposti da geni, cellule, carne e ossa».
“ESSERE MORTALE-Come scegliere la propria vita fino in
fondo” di
Atul Gawande (Einaudi 2014)